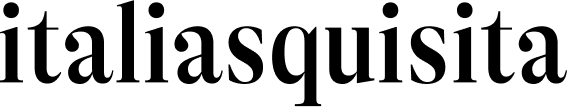Cocktail Bar
Ora ci si trattiene in città persino
al venerdì sera, perché è meglio bersi un cocktail scambiando
scemenze con gli amici che inveire in coda sulla Serravalle. E, senza
scherzare, il boom della mixology è un buon segnale del rinascimento
papillare della città, sintonizzata più di sempre sulle onde del
buon bere dei maestri anglosassoni: il ramos gin fizz di Dry,
la vodka zen del Rita, i vermut di Taglio o l’imperial
cicci del Morgan’s sono tutti buoni soggetti da whatsappare a
chi, all’ora dell’aperitivo, è incastrato in macchina
all’altezza di Gropello Cairoli. E gli stessi, imbottigliati di
nuovo a Genova Bolzaneto, schiumeranno rabbia a scorrere sui social
le cene degli amici rimasti.
Il milanese sceglie sempre meno i luoghi in cui si va per farsi notare. Preferisce mangiare bene. Conta il cuoco, la sua personalità, i piatti che prepara. La sua solidità sui classici o la capacità di variar spartito, con più o meno audacia.
Cucina Meneghina
Il primo gruppo è meno nutrito del
secondo: cucinare milanese a Milano non è di moda. Risotto giallo e
cotoletta resistono sopra a una manciata di pass cittadini, come il
dialetto dentro a quella decina di taxi. In questo senso, Cesare
Battisti del Ratanà è un filologo perché conosce a menadito le
archeo-ricette di Ottorina Perna Bozzi, le plasma sulle richieste
della contemporaneità (leggerezza e ingredienti formidabili) e,
soprattutto, copre una fascia clamorosamente scoperta in città: cibo
intelligente e conto decente. Come la coteletta di vitello
impanata nel burro di Giovanni Traversone della Trattoria del Nuovo
Macello, che è come dovrebbe essere: alta, rosata e senza effetti
collaterali. C’è poi tutta una serie di indirizzi off the
beaten track per provare ossobuco (L’Altra Isola), cassoeula
(Al Matarel), risotto al salto e rostìn negàa (Arlati).
Cucina Creativa
Storicamente, il contributo più efficace all’identità cittadina è però un altro, quello dei cuochi venuti da lontano. Il primo e più grande di tutti è Aimo Moroni, Il Luogo di Aimo e Nadia: salì da Pescia in Toscana nel 1946 per concepire lo Spaghetto al cipollotto o la Zuppa etrusca, piatti intramontabili. E come non pensare alle acrobazie tecno-emozionali del vicentino Carlo Cracco? Al veganismo ante-litteram di Pietro Leemann da Locarno (Joia)?
Tutti cuochi giudicati dalla comunità per le prestazioni, non per il passaporto. Qualcuno lo ha mai chiesto a Viviana Varese di Alice, il Mediterraneo che deborda dalle Colonne d’Ercole? Non lo hanno mai controllato nemmeno a Claudio Liu, il sino-emiliano che all’Iyo sintetizza Giappone e Italia.
A Matias Perdomo (Contraste), l’uruguayano che voleva essere se stesso. Nè ai bad boys del Mercato, milanesi travolti dallo street-food americano e asiatico. Certo, con l’Expo sono arrivati in tanti da ponente e da levante. Ma pochi lasceranno il segno dopo ottobre. Scommettiamo fin da ora sulla solida eleganza del pugliese Antonio Guida al ristorante del Mandarin Oriental, un potenziale gigante. Su Spazio, l’appendice milanese dell’abruzzese Niko Romito, finalmente un indirizzo piacevole in piazza Duomo. Se poi, come sembra, accetteranno di misurarsi con la città anche i pizzaioli venuti dallo spazio (per noi ora esiste l’impasto di Dry e poco altro), potremo confermare che a Milano c’è tanto lavoro. Quello delle nostre mandibole, affamate dopo esauste sgambate tra rinnovate bellezze.
Scopri la biografia e tutte le ricette di 🔗CESARE BATTISTI