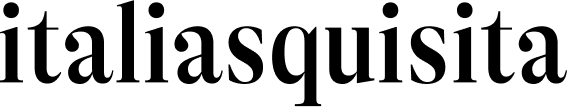Il pagliaccio di Anthony geovese
In questi quasi diciassette anni di Pagliaccio le avventure non sono mancate, grappoli di emozioni e sapori nuovi hanno attraversato numerosi stomaci di clienti romani e di tutto il pianeta. In sala l'evoluzione del servizio è cresciuta parimenti, senza interruzioni, come se il gioco trino tra cucina, pasticceria e sala fosse sempre stato unico e galoppante. Anno dopo anno lo chef italo-francese capisce che il suo Pagliaccio ha tutte la carte in regola per essere un esempio per le nuove generazioni e per gli stessi colleghi che vogliono sperimentare nuovi piatti e utilizzare ingredienti in quel momento ancora sconosciuti: spezie, pesci di altri oceani, quinto quarto romano e verdure asiatiche, proteine francesi del lusso come foie gras e piccioni con frutta dimenticata di terroir italiani come la mela cotogna.
Nell'aria capitolina molti si accorgono che Il Pagliaccio è diverso da tutto e da tutti, che lo chef è un sognatore con l'energia di un cingolato, che in sala sta succedendo qualcosa di nuovo, di sinergico con la cucina e viceversa. Molti giovani premono per andare a lavorare da loro, anche 16 ore al giorno, osservati in modo quasi paterno dal sous chef Francesco Di Lorenzo, anche lui in ballo fin dall'inizio in questa meravigliosa sfida culinaria. «Importante è sentire le nuove generazioni, loro che sono più attente all'innovazione della cucina; non bisogna chiudersi ma essere curiosi e aperti allo stimolo, collaborare con tutti quelli che gravitano attorno al Pagliaccio. Allo stesso tempo i giovani d'oggi credono di sapere tanto dai libri, ma a livello pratico non si sacrificano moltissimo. Non hanno ancora capito che noi cuochi viviamo in un mondo parallelo alla società, ed è per questo che dobbiamo sempre spingere fino in fondo, soprattutto nel mondo dell'alta cucina. “Chef, la mia ragazza non mi vede più, posso staccare qualche giorno?” “Beh, che ti devo dire, meglio per lei no?”. “Chef, questo sabato e domenica posso saltare il turno, vorrei andare a giocare a basket al parchetto, è la mia passione...” “Al posto di andare a giocare a basket al parchetto ti metto un canestro in cucina, così ti puoi sfogare!” ho risposto una volta ironicamente. Per i cuochi l'hobby più grande dovrebbe essere “dormire”...» dice quasi sbelliccandosi dalle risate.
Il presente luminoso del Pagliaccio
Dopo anni di successi e sgambetti, premi e fatica, “un due.. stella!” e tanti cambiamenti nello stile di cucina, si può forse affermare che ora non è più una cucina 'contaminata' quella del Pagliaccio, ora è la cucina di Anthony Genovese. Lo chef si è trovato, anzi ritrovato nelle sue origini e la metabolizzazione delle sue esperienze, con l'aggiunta della fermezza e dei risultati ottenuti in tutti questi anni. Tre anni fa Marion Lichtle ha fatto un passo indietro dalla cucina e si è dedicata, in modo perfetto, all'accoglienza, all'amministrazione e dunque alla parte più burocratica: dagli esordi quindi il ristorante, da 5 persone, è diventata un'azienda a tutti gli effetti.
Prima la sua cucina era molto provocatoria, un grido sulle barricate “sono fatto così”! La spezia prima era l'obbiettivo del gioco, ora è un equilibrato mezzo per raggiungere l'obbiettivo; è finita la provocazione fine a se stessa, ma è iniziata la provocazione calma, intelligente e produttiva, che fa godere nel risultato immediato ma alla lunga fa pensare e riflettere il cliente. La pulizia del piatto, la centralità del prodotto (sia esso un semplice cavolo romano o un agnello brado pugliese), due o tre elementi che fanno viaggiare la mente e fanno da coreografia per le papille, e alla fine due o tre elementi che accompagnano (come un imprevedibile bocciolo di tarassaco acetato).
E il futuro, a questo punto?
«Vorrei che il messaggio culinario fosse fatto con più umiltà e verità: in questo momento noi cuochi siamo sempre artigiani ma con in canna le bombe a mano della visibilità. È importante presentare un broccolo romano o una semplice rapa come elementi principali di un piatto, altro scenario invece la carne di Kobe, diverso e lontano, senza senso per noi che facciamo ricerca. Usare i prodotti che ci appartengono per portare un'ambasciata di sostenibilità intellettuale. Prima noi cuochi cercavamo i prodotti che non c'erano per necessità, ora lo facciamo per mostrare quanto siamo fighi. La soluzione potrebbe essere di continuare a essere fighi ma cercando la bellezza per necessità, non la provocazione o la notorietà. Un mio amico chef, di Doha, “si annoia” in mezzo al deserto, non ci sono prodotti da scoprire; essendo in un Paese ricchissimo quello che desidera lo ordina e gli arriva massimo in due giorni. Per lui non c'è quindi più ricerca né pensiero nel cercare qualcosa di perfetto e di istintivo, di bello e di valore. Che senso ha allora fare il cuoco?»
Leggi anche Anthony Genevese: lo chef cosmopolita
Nell'aria capitolina molti si accorgono che Il Pagliaccio è diverso da tutto e da tutti, che lo chef è un sognatore con l'energia di un cingolato, che in sala sta succedendo qualcosa di nuovo, di sinergico con la cucina e viceversa. Molti giovani premono per andare a lavorare da loro, anche 16 ore al giorno, osservati in modo quasi paterno dal sous chef Francesco Di Lorenzo, anche lui in ballo fin dall'inizio in questa meravigliosa sfida culinaria. «Importante è sentire le nuove generazioni, loro che sono più attente all'innovazione della cucina; non bisogna chiudersi ma essere curiosi e aperti allo stimolo, collaborare con tutti quelli che gravitano attorno al Pagliaccio. Allo stesso tempo i giovani d'oggi credono di sapere tanto dai libri, ma a livello pratico non si sacrificano moltissimo. Non hanno ancora capito che noi cuochi viviamo in un mondo parallelo alla società, ed è per questo che dobbiamo sempre spingere fino in fondo, soprattutto nel mondo dell'alta cucina. “Chef, la mia ragazza non mi vede più, posso staccare qualche giorno?” “Beh, che ti devo dire, meglio per lei no?”. “Chef, questo sabato e domenica posso saltare il turno, vorrei andare a giocare a basket al parchetto, è la mia passione...” “Al posto di andare a giocare a basket al parchetto ti metto un canestro in cucina, così ti puoi sfogare!” ho risposto una volta ironicamente. Per i cuochi l'hobby più grande dovrebbe essere “dormire”...» dice quasi sbelliccandosi dalle risate.
Il presente luminoso del Pagliaccio
Dopo anni di successi e sgambetti, premi e fatica, “un due.. stella!” e tanti cambiamenti nello stile di cucina, si può forse affermare che ora non è più una cucina 'contaminata' quella del Pagliaccio, ora è la cucina di Anthony Genovese. Lo chef si è trovato, anzi ritrovato nelle sue origini e la metabolizzazione delle sue esperienze, con l'aggiunta della fermezza e dei risultati ottenuti in tutti questi anni. Tre anni fa Marion Lichtle ha fatto un passo indietro dalla cucina e si è dedicata, in modo perfetto, all'accoglienza, all'amministrazione e dunque alla parte più burocratica: dagli esordi quindi il ristorante, da 5 persone, è diventata un'azienda a tutti gli effetti.
Prima la sua cucina era molto provocatoria, un grido sulle barricate “sono fatto così”! La spezia prima era l'obbiettivo del gioco, ora è un equilibrato mezzo per raggiungere l'obbiettivo; è finita la provocazione fine a se stessa, ma è iniziata la provocazione calma, intelligente e produttiva, che fa godere nel risultato immediato ma alla lunga fa pensare e riflettere il cliente. La pulizia del piatto, la centralità del prodotto (sia esso un semplice cavolo romano o un agnello brado pugliese), due o tre elementi che fanno viaggiare la mente e fanno da coreografia per le papille, e alla fine due o tre elementi che accompagnano (come un imprevedibile bocciolo di tarassaco acetato).
E il futuro, a questo punto?
«Vorrei che il messaggio culinario fosse fatto con più umiltà e verità: in questo momento noi cuochi siamo sempre artigiani ma con in canna le bombe a mano della visibilità. È importante presentare un broccolo romano o una semplice rapa come elementi principali di un piatto, altro scenario invece la carne di Kobe, diverso e lontano, senza senso per noi che facciamo ricerca. Usare i prodotti che ci appartengono per portare un'ambasciata di sostenibilità intellettuale. Prima noi cuochi cercavamo i prodotti che non c'erano per necessità, ora lo facciamo per mostrare quanto siamo fighi. La soluzione potrebbe essere di continuare a essere fighi ma cercando la bellezza per necessità, non la provocazione o la notorietà. Un mio amico chef, di Doha, “si annoia” in mezzo al deserto, non ci sono prodotti da scoprire; essendo in un Paese ricchissimo quello che desidera lo ordina e gli arriva massimo in due giorni. Per lui non c'è quindi più ricerca né pensiero nel cercare qualcosa di perfetto e di istintivo, di bello e di valore. Che senso ha allora fare il cuoco?»
Leggi anche Anthony Genevese: lo chef cosmopolita