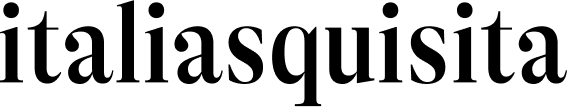Il processo di apprendistato è così lungo anche perché non passa dalle parole: si guarda e solo così si impara: “Per noi il sushi non si può insegnare, bisogna intuirlo: per esempio, la quantità di riso di un nigiri corrisponde più o meno al volume del dito con cui lo premo e gli dò forma. Quando una volta ho avuto l’ardire di chiedere al mio maestro: come si fa questo? lui si è molto arrabbiato e mi ha detto: osserva e sta’ zitto” chiarisce Takashi Shimazu, che insieme a Tetsuaki Maruyoshi è il sushi chef di Sushi B in via Fiori Chiari, 1. Basta questo per capire come il ristorante medio “con specialità sushi” di giapponese abbia giusto i sakura, i fiori rosa di ciliegio, dipinti sulle pareti: in città i ristoranti autentici si contano sulle dita di una mano.
“Per molti ristorante giapponese è sinonimo di sushi, ma questo non è corretto” continua Hirohiko “i ristoranti normali servono sashimi, antipasti e specialità a base di pesce cotto. I sushi bar, invece, fanno solo sushi”. “In Giappone il sushi è prezioso: si mangia una volta al mese, e di certo non a casa - la preparazione è complessa e macchinosa. Anche lì, certo, esistono tanti livelli: dai kaiten con i piatti a 100 Yen, 1 euro circa, fino al sushi misto a 300 euro come dal mitico Jiro Ono [lo chef ritratto nel documentario-culto Jiro e l’arte del sushi]” aggiunge. Questa doppia natura, tra alimento di lusso e specialità servita nelle bancarelle, si ritrova già nella storia del sushi. Secondo la leggenda a inventare il sushi sarebbe stata una donna anziana che, temendo i ladri, aveva nascosto del riso nel nido di un falco pescatore.
Quando era tornata a prenderlo aveva scoperto che il riso aveva fermentato, e che gli scarti di pesce del pasto degli uccelli si erano mescolati creando un abbinamento… interessante. Le vere origini del sushi sono più misteriose: la prima menzione della specialità - ma non ancora del nome- è contenuta in un dizionario cinese del quarto secolo che parla di pesce salato conservato nel riso cotto. Scopriamo così che l’utilizzo del riso come conservante del pesce ha avuto origine in Asia molti secoli fa: la fermentazione del riso produce acido lattico, che insieme al sale rallenta la crescita batterica e consente di estendere la vita del pesce. Questo “proto-sushi” fu introdotto in Giappone nel IX secolo, ed è diventato popolare con la diffusione del Buddismo, la cui dieta prevede di astenersi dalla carne.
Nel XIX secolo, a Edo - l’odierna Tokyo - i produttori di sushi utilizzavano un processo di fermentazione che prevedeva di disporre a strati il riso cotto condito con l’aceto e il pesce in una piccola scatola di legno per due ore. Negli anni Venti dell’Ottocento, Hanaya Yohei - spesso considerato il creatore del moderno nigiri sushi - aprì una bancarella nel quartiere Ryogoku dove per preparare il sushi gli bastavano pochi minuti: faceva con la mano una piccola pallina di riso che completava con una fettina di pesce crudo, appena pescato dalla baia di Tokyo, senza bisogno di fermentarlo.
Fu un successone: la folla costante di clienti rese il nigiri il nuovo standard nella preparazione del sushi. Nel settembre del 1923, in seguito al terribile terremoto di Kanto, a Tokyo ci fu una brusca diminuzione dei prezzi delle terre, e questo consentì a molti di coloro che avevano una bancarella di sushi (“yatai”) di aprire veri e propri ristoranti. A partire dagli anni ‘70, grazie alla refrigerazione e alla possibilità di spedire pesce fresco a lunghe distanze, la domanda di sushi di qualità in Giappone è esplosa. Gli Stati Uniti - e da lì, poi, l’Europa - sarebbero presto seguiti. Ma con differenze sostanziali: “Qui non c’è bisogno di un tempo di apprendistato così lungo, perché non si dà altrettanta importanza al sushi” spiega ancora Takashi “In Giappone preferiamo lavorare il pesce vivo, cosa che qui è impossibile.
Tutto il pesce, per quanto fresco, ci arriva già morto. A noi a volte piace persino mangiarlo da vivo” aggiunge ridendo. In Italia i clienti prediligono i maki, che in Giappone non esistono: il sushi vero è il nigiri, ma l’alga rende il gusto meno ostico per chi non è abituato al pesce crudo. Inoltre, qui la cucina giapponese è arrivata già meticcia, per tramite dell’America: basta pensare all’utilizzo della maionese - i maki California sono considerati quasi una ricetta tradizionale. Ma quali sono, allora, le caratteristiche dell’elusiva (almeno questo, almeno, è chiaro) esperienza autentica di sushi? Per cominciare, ci si siede non al tavolo ma al bancone, dove il sushi chef si dedica completamente al singolo cliente: al massimo 4 o 6 persone per turno. Il servizio è su misura: un pezzo di nigiri per volta, ruotato nella direzione della mano che lo prende - non si mangia con le bacchette - perché un sushi chef accorto avrà cura di riconoscere un ospite mancino. Anche la quantità di wasabi viene stimata in base all’espressione sul volto del cliente: l’accenno di una smorfi a tradirà che il boccone è stato troppo piccante, e nel corso del pasto lo stesso vale anche per la dimensione della polpetta di riso, decisa in base alla voracità dell’ospite.
La degustazione prevede una successione di nigiri, con tagli di pesce diversi. “Ma l’ingrediente più importante è il riso” puntualizza Ikeda Osamu di Osaka, storico ristorante giapponese in Corso Garibaldi 68 “non c’è molto che posso fare per il pesce, se non sceglierlo e frollarlo al meglio. La qualità del sushi dipende per il 70%-80% dal riso, che deve essere servito tiepido, non freddo”. Ma quante potranno mai essere le variabili? “La quantità dell’acqua in cui si cuoce il riso dipende dall’umidità nell’aria: è solo la lunga esperienza a guidare”, aggiunge Takashi. La varietà di pesci in un vero sushi restaurant è molto superiore a quella che troviamo in un ristorante generico (con un’importante eccezione: il salmone, che in Giappone non si mangia) e varia sulla base della stagione: ricciola, anguilla, sgombro, seppia, ricci di mare, o anche - nel caso di Osaka - proposte vegetariane a base di melanzana cotta alla griglia e avocado tagliato come un sashimi. Pensiamo al sushi come pesce crudo, ma questo non è sempre corretto.
Il tonno, ad esempio, va frollato, come la carne: appena pescato la carne è dura, servono 3 o 4 giorni di frollatura, sottovuoto a zero gradi per renderlo più saporito e lo stesso vale per il pesce bianco. Nessuna cena sarebbe completa senza tonno, servito in tagli diversi in base al contenuto di grasso: akami (la parte più magra), chu-toro (la ventresca media, molto equilibrata e saporita) and o-toro, la parte più grassa. Anche lontano dal Giappone, questo pesce rimane il più importante: “Quando il fornitore mi porta il tonno e non è buono, mi viene voglia di chiudere il ristorante” conclude laconicamente Hirohiko.
Fonte Italia Squisita 29