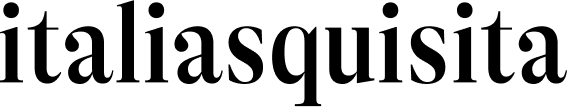Il tortellino viene fatto ancora a mano in tutta Emilia ed è una tradizione che conta su almeno mezzo millennio di storia. Quello bolognese inizia infatti a distinguersi nell’affollato panorama della pasta ripiena agli inizi del Cinquecento, quando viene riconosciuto come specialità cittadina.
La partenza è quantomeno singolare, visto che la prima ricetta dei Tortelli di caponi pollastri o altri ocelli alla bolognese prescrive una sfoglia di farina e latte di pecora ripiena di carne di pollo macinata, formaggio, uva passa e spezie. Inoltre i tortelli non vengono lessati, ma fritti nello strutto e serviti con una spolverata di zucchero.
Durante l’evoluzione dei secoli successivi la specialità petroniana ha accumulato innumerevoli varianti, prima di diventare il classico tortellino che tutti conosciamo. Ad esempio, rispetto agli esemplari attuali, fino alla seconda metà dell’Ottocento, l’unica carne ammessa come ripieno era quella dei volatili, in particolare quelli da cortile. A questa venivano di solito aggiunti altri ingredienti come il grasso di manzo - ricavato dal rognone o dal midollo -, parmigiano grattugiato, uova e spezie in polvere, di cui la noce moscata dei tortellini attuali è l’ultimo ricordo. Il maiale, che oggi ha il predominio assoluto del ripieno, inizia a comparire timidamente solo nel tardo XIX secolo, per poi esplodere nella ricetta artusiana. È infatti Pellegrino Artusi a dare l’impulso decisivo ai salumi introducendo mortadella e prosciutto nel ripieno: una ricetta destinata a fare storia.
Le differenze tra il tortellino antico e quello attuale non si fermano qui. Anche la forma era diversa e mancava completamente la tipica punta all’insù. La ragione è che la pasta veniva tagliata a circoletti - e non in quadrati - con un bussolo o un bicchierino. Nel tardo Ottocento viene specificata anche la misura che doveva corrispondere al diametro delle 5 lire d’argento, ovvero 37 millimetri. Il ripieno veniva quindi racchiuso nella pasta formando una mezzaluna, per poi unire le punte e formare il “cappelletto”.
Anche il modo di servirli poteva variare e, se nel Seicento i tortellini venivano usati come accompagnamento di anatre o capponi lessi, nei secoli successivi finiscono nel ripieno dei ricchi timballi al forno. Una specialità, quest’ultima, che in qualche modo è sopravvissuta, rilanciata da Bruno Barbieri con lo ‘Scrigno di Venere’.
Il modo più comune di gustarli, oggi come allora, era però in un brodo ristretto, ma chi inorridisce di fronte alla panna o alla crema di parmigiano sbaglia, visto che i tortellini serviti asciutti sono tradizionali quanto quelli in brodo [...]
Estratto di "Mezzo millennio di tortellini" di Luca Cesari su ItaliaSquisita 52.
Non perdere l'ultimo numero di ItaliaSquisita, visita il nostro shop e scopri di più!
Ph. Rolando Paolo Guerzoni