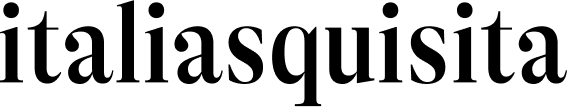La fede di Milano nel calice delle 19 circa (prima delle 18 no, solo domenica o in vacanza) ha radici antiche e insieme è faccenda del Novecento. Si può far risalire - in tutta Italia - alla cultura latina la consuetudine di precedere l’estremo pasto di giornata a una prima mandata di vino spesso e pietanze leggere. Ma è all’incrocio della civiltà contadina con le città risorte nel Rinascimento che si trovano le tracce della moderna ebbrezza da tramonto. Da un lato la nobiltà (o la borghesia ricca in cerca di titoli) che della terra consumava i frutti, dall’altro i vertici dell’organigramma agricolo feudale che assaggiavano volentieri. Il padrone abbinava il fine turno a salumi (Italia centrale e Val Padana), pescato, grani, semi, frutti (resto d’Italia).
Il futuro corre invece lungo la direttrice est/ovest che nel Settentrione lega la Torino sabauda alla decadente Venezia, passando per la ricca Milano (città che come la Serenissima era dominio austriaco, mentre in Piemonte il giogo, più lasco, era francese). Avanguardie esposte alle suggestioni continentali in cui apparve un giorno il vermouth. Miscela di moscato Canelli erbe e spezie, messa a punto, leggenda vuole, dal farmacista Benedetto Carpano, garzone di fronte alla reggia dei Savoia. Fu prototipo di tutti distillati su scala industriale. Il sapore e le (false) proprietà medicamentose conquistarono al volo l’intellighenzia piemontese risorgimentale, stanca di bere sempre caffè nei circoli dove tramava l’Unità. A Milano nacque invece da Davide Campari (ma non va dimenticata nemmeno l’epica del Fernet dei Branca) il celebre bitter il cui rosso fa Milano più del bianco rosato del Duomo [...]
Estratto di "Il culto urbano dell'aperitivo" di Simone Mosca su ItaliaSquisita 52.
Non perderti l'ultimo numero di ItaliaSquisita, visita il nostro shop!