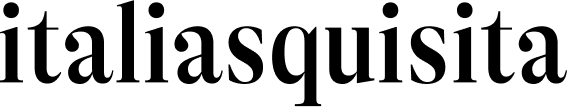Eccoci in compagnia di Giorgio Locatelli, chef lombardo che fin dall’adolescenza si è sperimentato all’estero ed è cresciuto in vari Paesi europei, trovando infine a Londra il suo centro creativo. Londra, con la sua cucina e popolazione multiculturale, lo ha fatto sentire a casa.
Dopo diverse esperienze in prestigiosi ristoranti, tra cui lo “Zafferano”, ha aperto nel 2002 un suo ristorante di proprietà, la “Locanda Locatelli”, che dal 2003 è insignita della stella Michelin. Ma altro che punto d’arrivo, la Locanda è base di partenza dei tantissimi progetti in cui si lancia l’indaffarato e simpaticissimo Giorgio, proiettato nel futuro, nella comunicazione, ma anche fedele alle sue tradizioni.
Diciamo subito la verità, chef si nasce o si diventa?
Posso dire di esserci proprio nato in cucina, io. Nell’aprile 1962 mio nonno, elettricista idroelettrico, ha dato vita ad un hotel con ristorante sul lago di Comabbio, vicino a Varese. Vivevamo tutti lì. Sono stato abituato fin da piccolo a sapere che le domeniche e di Natale si lavora di più, e mi è sempre sembrato normale. A me poi piaceva da matti stare in cucina. L’ambiente era più informale, schietto, niente giacche e cravattini. Ero completamente a mio agio con i giovani e trasgressivi cuochi che popolavano i nostri “dietro le quinte”.
E poi, sei scappato?
Sì, Corgeno mi stava piccolo, e dopo il militare ho scelto di ampliare i miei orizzonti. Non mi vedevo come “cuoco” italiano, volevo diventare uno che conta, volevo diventare “francese”, come si diceva allora, un vero “chef”. Formato sul “Répertoire de la cuisine” agognavo di raggiungere il “Savoy”, battezzato da Auguste Escoffier, dove tra l’altro sapevo che vi era una lunga tradizione di cuochi italiani. Mi presero, con mia grandissima gioia, e per quattro anni sono stato immerso nelle sue grandi cucine. Da lì sono passato a Parigi, per un paio d’anni, al “Restaurant Laurent”. Non è stato un periodo facile. Mi sentivo “immigrato”, mi sperimentavo su una cucina che era considerata in assoluto la migliore ma non era la mia, e lo sentivo. Me ne sono andato buttando via il cappello, volevo quasi rinunciare …
Cosa ti ha fatto cambiare idea?
Un viaggio in moto in giro per l’Europa e molte riflessioni; ho capito che volevo tornare alla cucina italiana con tutte le conoscenze che avevo acquisito. Gualtiero Marchesi è stato per me, e penso anche per molti altri, un vero faro in questo. Lui ci ha fatto capire che anche gli chef italiani potevano farsi valere. Ha dato dignità a tutti noi e alla cucina italiana, col suo esempio. E ci ha seguito tutti, come un papà.
Inizia quindi il periodo londinese, l’Olivo e lo Zafferano …
Avevo avuto un’offerta per tornare a Londra con carta bianca in un piccolo ristorantino in Eccleston Street, l’”Olivo”. Ho imparato moltissimo in quel periodo, e mi sono divertito come un matto. Avevamo una sessantina di coperti, ed in tutto eravamo quattro in cucina e due in sala; come puoi immaginare, era un contesto molto “basic” per me che arrivavo dalle scuderie da 150 cuochi del “Savoy”. Ho iniziato a capire cosa significa fare il ristoratore; prima per me il piatto finiva quando lo consegnavo al cameriere, fatto, il mio lavoro concluso. Invece all’Olivo ci occupavamo tutti di tutto, e ho capito cosa significasse avere uno sguardo d’insieme, una visione per far funzionare al meglio le cose. Poi nel ’95 abbiamo iniziato una partnership con lo “Zafferano”, il primo ristorante italiano a Londra ad essere premiato con una stella Michelin.
Come nasce infine la “Locanda Locatelli”?
Nel 1995 mi sono sposato con Plaxy. Eravamo praticamente co-proprietari all’Olivo, ma volevamo aprire un ristorante nostro. Nasce così nel 2002 la “Locanda Locatelli”, che ha avuto un ottimo feedback da subito, come dimostra la stella Michelin che abbiamo conquistato nel 2003.
Abbiamo ripercorso i passaggi avventurosi della tua carriera. Andiamo al sodo ora, cominciamo a “parlare come si mangia” … Qual è il tuo modo di cucinare?
Da noi, a Corgeno, ognuno faceva il suo, in un ottica molto collaborativa. È stato per me come avere un “pattern”, un sentiero già tracciato nella mente, che mi veniva naturale seguire. Non ho mai avuto un’idea rigida della divisione dei compiti e dell’organizzazione, ma piuttosto l’attenzione a far sì che tutti possano collaborare al progetto.