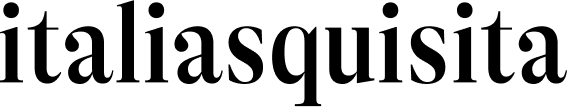Questi fattori, combinati, comportavano un’incisività minima del cliente sulla scelta della bottiglia, con il sommelier costretto a orientare la preferenza all’interno di una piccola rosa di opzioni, a dispetto di un’offerta ampissima della carta, per evitare il corto circuito che inesorabilmente si sarebbe creato tra sala e cucina nel caso di prolisse valutazioni; la scelta di frequente premiava la versatilità, il vino passe-partout, ma quell’unica bottiglia difficilmente riusciva a valorizzare al meglio portate diversissime e “scollegate” tra loro. Una svolta importante per il food pairing arriva con i menu degustazione, dove la sintassi dei piatti non solo viene incorniciata in un percorso logico, ma elaborata anche in considerazione dell’abbinamento con il vino, pensiamo ai casi di degustazioni che prevedono tanti calici quante sono le portate.
Una radicalizzazione dell’unicità di ogni passaggio, questa, che provoca però un lievitare dei costi a più di un livello, dall’approvvigionamento dei vini alle dinamiche del servizio. Si assiste a un vero e proprio ribaltamento: mentre in passato il sommelier, demiurgo della cantina, veicolava in modo cruciale l’offerta e la decisione del cliente contestualmente all’ordinazione, ora a comandare è piuttosto il menu, la cui complessità, oltre a investire una scelta a priori delle referenze, ne porta a tavola una quantità fin troppo generosa. Ecco perché si inizia a pensare a delle alternative, come accoppiare lo stesso calice a più di una portata, abbassando i costi e migliorando al contempo anche il servizio. Interessante l’intuizione di alcuni sommelier secondo i quali, declinando le sfaccettature del vino secondo uno stato fisico (la temperatura) e uno stato strutturale (il bicchiere), con 2 o 3 referenze si può efficacemente accompagnare una degustazione importante, sfruttando i diversi modi in cui lo stesso vino è in grado di esprimersi “trattato” a diverse condizioni.
Più audace, al limite forse dell’egotismo, la visione di quegli chef che considerando le proprie creazioni perfette, finitamente complete al punto da rischiare di essere “rovinate” dalle suggestioni offerte dal vino, caldeggiano la sua sostituzione con l’acqua. E qui si apre un mondo, poiché lungi dall’essere neutra, l’acqua può diventare quantomeno insidiosa poiché tende ad accentuare alcune caratteristiche dei cibi che di certo non vale la pena sottolineare, come i retrogusti ferrosi, senza considerare il frescume tipico dell’uovo o l’odore che resta nel bicchiere in seguito a bocconi a base di pesce: affidarsi in toto alla purezza dell’acqua (sull’esempio, per citarne uno, del pluripremiato chef americano Patrick O’Connell) non prescinde da alcune sfide di cui tener conto, dalla creazione di una lista di acque di valore debitamente supportata da un water sommelier a disposizione dei clienti, fino alla necessaria, e potenzialmente frequentissima, sostituzione dei bicchieri durante il pasto [...]
Estratto di "Le forme del pairing" di Andrea Grignaffini su ItaliaSquisita 53
Non perderti il numero autunnale di ItaliaSquisita, visita il nostro shop e abbonati!
Ph. DepositPhotos